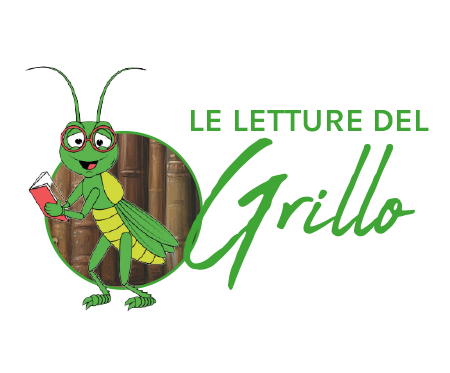COME L’ARANCIO AMARO
Romanzo di Milena Palminteri, edito da Bompiani, Milano, 2024
La nascita di una bambina è al centro di un oscuro intrigo in una Sicilia ancora di stampo feudale. Diventata donna vuole scoprire la verità sulle sue origini.
LA STORIA
La vicenda, ambientata in Sicilia, si svolge in due spazi temporali distinti. Il primo comprende l’arco degli anni dal 1924, in cui Carlotta Cangialosi nasce a Sarraca, un paesino in provincia di Agrigento, nel palazzo di famiglia dei baroni Cangialosi, fino al 1932, in cui la bambina compie otto anni. Carlotta non ha mai conosciuto il padre, il barone Don Carlo, morto in circostanze mai chiarite la notte della sua nascita. La madre Nardina, una giovane bella e raffinata anche se di origini plebee, che ha potuto studiare grazie ai soldi di una madre faccendiera ed ha uno spirito libero e indipendente, riesce ad offrire a Carlotta solo una tenerezza svogliata, un amore annacquato, pur non facendole mancare nulla. La bambina cresce sentendo dentro di sé un grande vuoto affettivo , colmato almeno in parte dall’amore incondizionato che Sabedda, una serva di casa dal carattere indomito e selvaggio, nutre per lei. Nuvole scure si addensano però su palazzo Cangialosi, Sabedda si vede costretta a fuggire dalla dimora senza un avvertimento o un saluto e questa perdita improvvisa e inaspettata acuisce ancora di più in Carlotta il senso di abbandono.
Nel 1960 ritroviamo Carlotta, diventata una giovane donna di trentasei anni, a dirigere dopo i suoi studi in legge l’archivio notarile di Agrigento. Qui scopre per caso un documento risalente aglli anni della sua infanzia che la sconvolge. L’atto si riferisce alla denunzia che la nonna paterna donna Rosetta aveva rivolto a carico della nuora Nar dina affermando che non era stata lei a partorire Carlotta, ma che l’aveva comprata.
dina affermando che non era stata lei a partorire Carlotta, ma che l’aveva comprata.
Questo spiegherebbe per Carlotta l’ansia di amore, il buco affettivo che l’hanno sempre fatta soffrire, in particolare nella sua infanzia.La giovane decide di intraprendere delle indagini. La sue ricerche, l’arrivo di una persona venuta dal passato e una lettera custodita dall’amato zio Peppino che ha sempre vegliato su di lei la condurranno alla verità.
DAL TESTO
Dallo scalone di marmo se ne scendeva lento lento, il toscano appena acceso che lo avvolgeva in nuvole di fumo azzurro, Don Calogero Licata con quella sua spavalda figura di campiere fuori e mafioso dentro.
Bastiana trattenne il fiato e sgranò gli occhi ché le sembrò un segno del destino. Era lui l’uomo dei miracoli, l’ombra che agiva e nessuno sapeva, quello cui spettava dividere i buoni dai cattivi salvo, all’occasione, invertire i giudizi, quello che faceva piovere mentre il sole splendeva. Bastiana si diede sulla fronte un colpo a mano aperta e punì la sua stolidaggine.
Mafioso era mafioso, su questo non c’era da avere il dubbio della calunnia tanto si era diffusa la fama di santo e giustiziere. Batteva tutte le campagne sarracesi ora campiere, più spesso fittavolo, in pectore già padrone. La situazione di ogni famiglia, nobile e no, era scritta nella sua testa precisa ed esatta che neanche nei registri dell’anagrafe al municipio e in quelli del catasto.
[…]
Nardina sconfortata ammise con se stessa che tornare indietro non poteva più, le prime pedine erano state mosse. La prese insopprimibile il risentimento nei confronti della madre: comandava ogni sua scelta, la muoveva come marionetta, la svuotava di ogni volontà disgustandola di se stessa. Si rimproverava la sua soggezione a lei e l’incatacità di negarsi ai suoi comandi. Tornò a letto e desiderò ucciderla, l’avrebbe sepolta, annegata, nascosta in un anfratto dopo averla avvelenata, nessuno ne avrebbe mai dovuto trovare neanche il cadavere tanto lei provava vergogna delle sue disonestà e dei suoi traffici.
Ma il suo stesso odio le faceva paura e alla fine convenne con la sua coscienza che era stata lei, lei proprio, a consentire e sollecitare i piani della madre e di nuovo disse sì.
[…]
Quando ero nica, ero io a pretendere che mi baciasse, che avesse per me quei minzigghi stucchevoli che ogni madre dedica ai figli. Meglio sarebbe stato se me ne avesse sommersa davanti agli altri, se avesse affondato con forza le sue labbra sulla mia guancia, se mi avesse fatto mancare il respiro.
E invece si ostinava nell’esatto contrario e ogni volta il mio piagnucolio perché mi accontentasse si spegneva stanco in un bacetto veloce e nascosto, sempre per quella storia antica del pudore d’amore che mai va mostrato. E io di nuovo attendevo un bacio diverso, d’impeto e forte, che annullasse l’amore tenuto nascosto, un bacio che fosse solo di noi due, segreto e raro purché certo come una firma.
[…]
Sabedda è stata la gioia del possesso. Lei era mia, dove e quando volessi, la certezza del suo amore mi rendeva carnefice, ma lei era troppo felice di essere vittima, non ero solo io che di lei profittavo, era lei che, inerme, a me si offriva. Violenta, la baciavo quando mi accontentava in ogni capriccio e con altrettanta violenza la mordevo sul braccio se mi contrastava. Ogni tanto me ne stancavo, mi inorgoglivo nel mio ruolo di figlia di baroni, anche se dei patrimoni di un tempo ben poco restava. La avvertivo estranea a me e a mia madre Nardina, come fossimo di razze diverse, non sempre capivo il suo dialetto stretto come una lingua straniera e a volte odiavo quell’odore di sole che brucia di cui erano impregnate non solo le vesti ma anche la sua pelle.
Come tutte le cose che diventano oro quando le perdi, piansi tutto di noi quando sparì d’improvviso.
[…]
Azzardo la domanda:” Signor Licata, Sabedda vi ha parlato di me?”.
Cerca le parole nel mare quieto che ci sta davanti, indugia.
“Io, signora Carlotta, vi sapevo. Di persona non vi conoscetti perché da Sarraca me ne andai il giorno che vossia nascìu…me ne andai a travagghiare a Girgenti, ma per tant’anni sono stato campiere nelle terre di sua nonna e del figlio don Carlo…”
“Allora voi avete conosciuto mio padre! E sapete cosa accadde la notte della sua morte?”.
“Quale padre?”
Lo sguardo suo allarmato mi colpisce come una lama.
ALCUNE RIFLESSIONI
In un paesino della Sicilia negli anni venti, dove i baroni sperperano le loro ricchezze ed esercitano il potere sui villani che subiscono i soprusi, mentre sta dilagando il fascismo colluso con la mafia locale, si incontrano i destini della diafana Nardina e della selvaggia Sabedda. I due personaggi, come del resto le altre figure del romanzo, anche quelle minori, sono rappresentazioni a tutto tondo, persone vere, reali di cui, oltre l’aspetto fisico, conosciamo le luci e le ombre del carattere. A farci capire il loro pensiero, i loro propositi, a permetterci di anticipare i loro intrighi bastano un baluginio degli occhi, un gesto improvviso che tradisce emozione, turbamento o sete di vendetta, la piega dolce o amara di un sorriso. Così conosciamo l’eterea Nardina, colta e raffinata, di cui ammiriamo la mente aperta a nuovi orizzonti ma compatiamo l’ incapacità di amare in maniera incondizionata e non egoistica. Sabedda, tanto diversa da lei, una “fimmina di casa” rozza, ignorante e selvatica, ci attira per l’intensità delle sue passioni, siano esse di amore profondo o di odio e desiderio di vendetta per i soprusi patiti. Carlotta condivide con Nardina lo spirito libero e la consapevolezza delle proprie capacità derivata anche dall’istruzione a cui ha potuto accedere e con Sabedda un certo aspetto indomito e ostinato che fa parte della sua indole, per cui “è pronta a ferirsi, a sentire le ossa in frantumi e la pelle bruciare pur di sapere la verità”. Intorno a queste tre donne protagoniste ruotano tanti altri personaggi ognuno importante a suo modo per il ruolo svolto nella vicenda, come la “currera” Bastiana, avida trafficante di servizi e di favori con “occhi come spilli perforanti”, il campiere mafioso don Calogero, che ha “l’anima dannata” per i delitti commessi ma trova una via di redenzione nell’amore per la sua donna, o l’affettuoso avvocato zio Peppino, ironico provocatore e convinto antifascista, che Carlotta definisce “il mio solo padre, la mia sola madre”.
L’aspetto storico sociale, delineato attraverso l’affermarsi del fascismo nel paese di Sarraca, il progressivo declino economico dei nobili, i servizi mafiosi offerti sia ai ricchi che ai poveri in cambio di ricompensa, si intreccia nel romanzo alle vicende umane dei personaggi, non solo come semplice sfondo ma anche come parte integrante e causa delle loro passioni e delle loro pene.
La prosa, intrisa di dialetto, ha una connotazione forte, sa essere tagliente ma anche tenera in certi vezzeggiativi propri della lingua siciliana: “pupidda”, “le manuzze niche niche”, “le orecchie due farfalluzze”. E’ un linguaggio che ben si adatta all’immagine dell’albero dell’arancio amaro evocata dal titolo del romanzo, una pianta che ha rami spinosi ma delicati fiori bianchi profumati.
Spetterà al lettore scoprire il significato del titolo e a trovare la parte mancante della similitudine.
 L’AUTRICE
L’AUTRICE
Milena Palminteri, nata a Palermo, vive a Salerno dove è stata responsabile dell’Archivio notarile. Da molti anni si occupa di scrittura. “Come l’arancio amaro” è il suo primo romanzo.